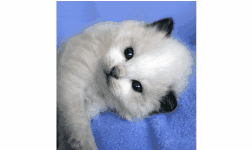Finora… (di Alessandro Dehò)
(Giovanni 2,1-11)

Entra nel mondo come lievito, invitato tra gli invitati. Gli amici, la madre, un po’ di festa, questa la sua solennità, questo il suo tempio. Entra tra le voci e le risa, muove i suoi passi tra i costumi di una religione che prova a dare senso al vivere, cammina nel cuore di un umano che prova a promettersi eternità per sconfiggere almeno per un poco la morte. Entra in un mondo profumato di carni arrostite al fuoco, di pane e di vino, di danze, musiche, risate sguaiate, tristezze velate, frasi urlate e parole sommesse… entra nella vita che non ha vergogna di mostrarsi così come è, a Cana, in un matrimonio come tanti, entra, Gesù, da invitato.
Poi diranno che a Cana tutto è iniziato, che è stata inaugurata l’Alleanza definitiva, che l’Antico Testamento stava diventando Nuovo e che lo sposo atteso era proprio Gesù… ed è tutto vero però, dopo. Intanto Gesù è invitato tra gli invitati. E accetta l’invito. E credo che tutto inizi davvero così, anche per noi. Se vogliamo dare inizio ai segni cioè rinascere a una vita significativa per noi e per gli altri dobbiamo innanzitutto accettare l’invito che la vita ci offre. Invito all’umanità. Accogliere con gratitudine di essere stati invitati da questa vita anche se spesso sembra un matrimonio tra disperati che non riescono a portare a termine mezza festa. Accogliere l’invito significa entrare nella storia e accoglierne i profumi e gli odori, le danze e le risa anche sguaiate, significa non deridere lo scambio umano di promesse di eternità anche se lo sappiamo, sono sempre troppo enormi. Non stare fuori dalla festa. Farne parte. Da invitato tra gli invitati. Maturando un profondo legame con tutti gli altri commensali, imparando a guardarli con tenerezza e misericordia. Ridere con loro e mai di loro. Mi pare che questo sia il vero segno di inizio che Gesù ci consegna, ben prima dell’acqua in vino c’è questa totale immersione nell’umanità. Ospiti dell’umano, a noi il dolce impegnativo compito di farlo fiorire. Per noi e per gli altri. Trasformandoci, vero miracolo, da anfore vuote in sorgenti sorprendenti di vita.
Poi il vino finisce, lo sappiamo. Maria si accorge. Lei è donna, è madre, la vita le ha già insegnato a partorire uno sguardo attento al mondo. Dopo scopriremo che quel vino è simbolo e segno di tutte le feste umane esaurite, di una Alleanza con Dio che andava rinnovata… dopo. Intanto è vino finito. È storia che interroga. E questo è l’altro nuovo inizio prima dell’acqua in vino. L’invitato Gesù comprende che dare inizio ai segni, significa lasciarsi ferire dalla vita. Che quel vino finito, quella festa che implora un nuovo tempo, quel mondo che Maria riesce a far pregare è bordo vertiginoso da oltrepassare. Un punto di non ritorno certo, un cominciare a dare la vita, la propria, come Segno. È bellissimo questo Gesù che impara dalla vita che accade. Perché la verità fiorisce dal nostro rapporto con gli eventi. Siamo chiamati, ed è questa la fede, a lasciare che la vita ci ferisca. Anche con le sue improvvise richieste. È finito il vino: quando un amore si inceppa, quando la malattia increspa la calma, quando mi perdo, quando mi lasciano, quando non trovo casa, quando non capisco più la persona che amo… vino finito. E’ la vita che interroga. E diventa significativa se io imparo a rispondere con la vita stessa. Perché da Cana Gesù sta imparando. Per quando giungerà la sua ora. Per quando, in altra cena ultima, a rimanere sarà il vino ma lui no, lui sarà chiamato a “finire”. Impara Gesù dalla vita, e quando sarà chiamato a trasformare non solo acqua in vino ma vino in sangue sarà Cana portata a compimento. Impara Gesù dalla vita, perché il Segno vero, una vita significativa, è saper imparare, e quando sarà solo, festa finita, nell’orto degli Ulivi sicuramente ricorderà le parole di Maria “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” e allora alzerà lo sguardo a quel cielo senza stelle e ricordando il vino di Cana e della ultima Cena dirà: se puoi allontana da me questo calice ma dimmi quello che vuoi… e qualsiasi cosa dirai io lo farò. Fede, fede vera, è lasciare che la vita ci interroghi, è imparare a bere il calice fino in fondo, è accettare che abbiamo bisogno di tempo per arrivare alla nostra ora, è non far passare le cose invano, è imparare. Imparare a non pretendere che la vita segua i nostri tempi ma amare così totalmente la storia da trasformarla, vero segno, da acqua che scorre verso la morte a vino che sorprende di possibilità inaspettate di alleanza. È lasciar scorrere la vita incontro a noi, lasciare che ci interroghi e non limitarsi a subirla: dalla roccia di una ferita può scaturire vita nuova.
E poi è il rumore delle anfore che si riempiono. In fondo la disperazione non è il dolore ma il vuoto. E quello che succede è che in quel contesto di festa nessuno si accorge ma Gesù dà inizio a un Segno nuovo. E il Segno è che è finito il tempo della purificazione e iniziato il tempo della festa. Anche se ancora non l’abbiamo compreso. Fede, fede vera, da quel giorno di Cana, non è credere in un Dio che ci immagina puri, senza scorie, immacolati di fronte alla vita… da quel giorno di Cana è ancora più chiaro che Dio ci immagina vita profumata e calda come sorso di vino. Calore e profumo di terra e di cielo, la vita che abbassa le difese e scioglie la parola, la vita che chiede di essere cantata e condivisa: la vita viva. Invitati a vivere passando dalla logica del sacrificio alla grammatica della passione. Non siamo stati invitati al mondo per essere puri ma per continuare a cercarci, uomini tar gli uomini, anfore riempite di profumo, per dare inizio ai segni, cioè per rendere questa vita, tutta la nostra vita un Segno. Segno di una speranza, segno di un incontro, segno di una vita che chiede di condividere il calore di amare e di lasciarsi amare. Segno di una vita che quando crede nell’uomo profuma di festa, di vino buono.
Solo così si trasforma la vita. E segno, segno vero, non è l’acqua in vino ma la stanchezza in stupore, l’esaurimento in rinascita: tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Segno, segno vero, è permettere una delle dichiarazioni di fede più belle e commoventi del Vangelo. Fede nella vita che finalmente si mostra per quello che è: promettente. Promette di non vivere di esaurimento in esaurimento, promette di non illudere con sogni buoni che poi si incagliano in realtà usurate, promette di non ingannare, approfittando dello stordimento, cambiando vino in tavola. È tempo del finora: quando il vino buono viene tolto dalla cantina. E’ tempo che nelle nostre Comunità si ricominci a condividere il profumo di una vita promettente creando le condizioni perché fiorisca. È tempo di imparare la trasformazione vera che non è quella dell’acqua in vino ma quella dello sguardo del maestro di tavola che riconosce, stupito e grato, la bontà della vita.