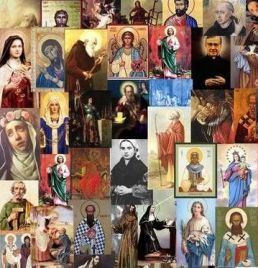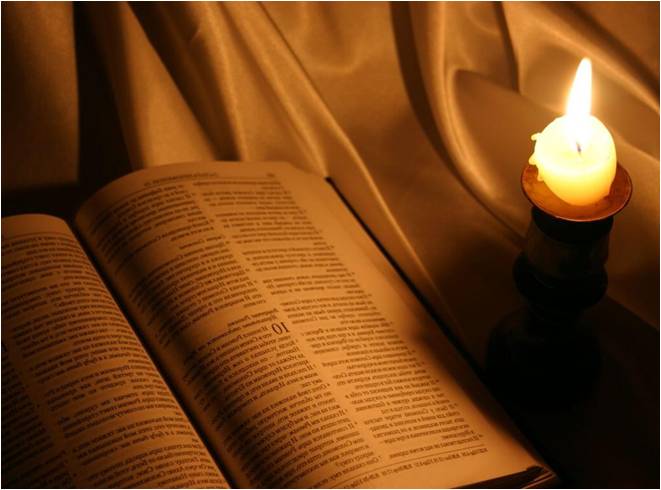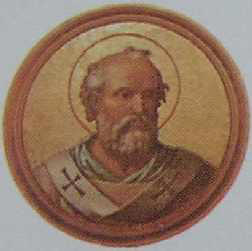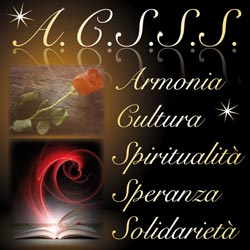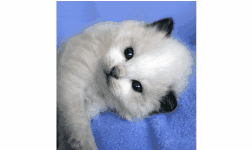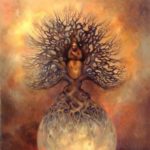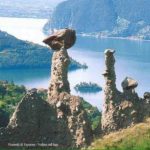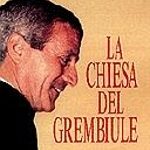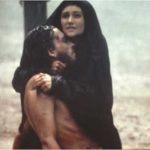novembre 2024
2 Novembre: una ricorrenza
2 NOVEMBRE: GIORNO DEI DEFUNTI
(dalla bacheca di P.Alberto Maggi)
|
Il messaggio dei vangeli è che attraverso la morte la persona continua la sua esistenza in una diversa dimensione, in una continua crescita e trasformazione di se stessa verso la piena realizzazione, come recita il Prefazio per la messa dei defunti: “La vita non viene tolta, ma trasformata”. È la vita stessa che continua, non un’essenza spirituale dell’individuo (l’anima). La vita, trasformata e arricchita dal patrimonio di bene che l’individuo reca con sé, entra nella pienezza della condizione divina, come scrive l’autore dell’Apocalisse: “Beati fin d’ora i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono” (Ap 14,13). Unendo paradossalmente due termini contrastanti quali la morte e la beatitudine, l’autore afferma che la morte fisica non ha l’ultima parola sulla vita del credente. La morte non è una sconfitta o un annientamento e neanche l’ingresso in uno stato di attesa, ma un passaggio a una dimensione di pienezza definitiva. Per questo la risurrezione non è una seconda vita né una nuova vita, ma la piena realizzazione di questa unica vita che l’uomo ha. Eterno riposo? I defunti non stanno al cimitero, il luogo dei “resti mortali”, ma continuano la loro esistenza nella pienezza di Dio, è questo il significato di “Riposeranno dalle loro fatiche”. Il riposo al quale allude l’autore non indica la cessazione delle attività, ma la condizione divina, come il Creatore che “compì l’opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno” (Gen 2,2). Con la morte l’individuo riposa dalle opere compiute nella sua esistenza terrena, ma viene chiamato a collaborare all’azione creatrice di Dio comunicando vita agli uomini: “Chi è entrato infatti nel suo riposo, riposa anch’egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie” (Eb 4,10). La morte non conduce a un eterno riposo inteso nel senso di un divino ozio per tutta l’eternità, ma all’attiva e vivificante collaborazione con l’azione del Creatore. In quest’azione creatrice l’amore che il defunto aveva verso i suoi cari non viene affievolito, ma arricchito dalla stessa potenza d’amore del Padre. La morte non allenta i rapporti umani ma li potenzia. L’unica cosa che l’uomo porta con sé nella nuova dimensione di vita sono le opere compiute nella sua esistenza terrena. Le opere con le quali l’uomo ha trasmesso vita agli altri, sono la sua ricchezza, quel che hanno resola vita eterna già in questa esistenza, innescando nell’individuo un processo di trasformazione che non viene fermato dalla morte, ma potenziato. La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronun-cialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace. Henry Scott Holland (1847-1917). Canonico della cattedrale di St. Paul (Londra). |
Ognissanti e Defunti: preghiera di Francesco
Ognissanti e Defunti
(la preghiera di Papa Francesco)
Ci prepariamo a celebrare due importanti ricorrenze: la solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione dei defunti. «Sono giorni di speranza», ha detto papa Francesco lo scorso anno nell’omelia della messa celebrata al cimitero monumentale del Verano, a Roma, dove tornerà anche quest’anno. E ha spiegato che «nel giorno dei Santi e prima del giorno dei Morti è necessario pensare un po’ alla speranza che ci accompagna nella vita. I primi cristiani dipingevano la speranza con un’ancora, come se la vita fosse l’ancora gettata nella riva del Cielo e tutti noi incamminati verso quella riva, aggrappati alla corda dell’ancora. Questa è una bella immagine della speranza: avere il cuore ancorato là dove sono i nostri antenati, dove sonoi Santi, dove è Gesù, dove è Dio».
Ad accomunare le due ricorrenze, per Francesco, è «la speranza che non delude». Ma dove e come hanno avuto origine? Va detto, innanzitutto, che solo la prima (Ognissanti) è una festa di precetto, che prevede cioè l’obbligo per i fedeli di partecipare alla messa. Vi si celebrano l’onore e la gloria di tutti i Santi in ossequio al credo cristiano della “Comunione dei Santi” che Paolo VI, nel “Credo del popolo di Dio”, definiva «la comunione di tutti i fedeli di Cristo, di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati in cielo: tutti insieme formano una sola Chiesa; noi crediamo che in questa comunione l’amore misericordioso di Dio e dei suoi santi ascolta costantemente le nostre preghiere».
La festa dei martiri la festa dei santi
Le origini della celebrazione risalgono al IV secolo (le prime tracce portano ad Antiochia, in Siria) quando la Chiesa celebrava la memoria dei martiri della fede il 13 maggio. A cambiare la data di quella che, nel 615, Bonifacio VI aveva ufficializzato come Festa di tutti i Martiri, fu Gregorio III che scelse il 1° novembre (secondo alcuni per “cristianizzare” la festa pagana del Capodanno celtico che cadeva proprio nei primi giorni di novembre). In seguito, su richiesta di Gregorio IV, il re dei Franchi Luigi il Pio decretò festa di precetto quel giorno che, da Festa di tutti i Martiri, diventò la Festa di Ognissanti. è grazie a questo nome che oggi, comunemente, vi si festeggia anche l’onomastico di tutte le persone il cui nome non compare nel calendario cristiano (adespoti). Dal 1° giugno 1949 il giorno di Ognissanti è stato inserito tra quelli considerati festivi.
Fiori, dolci e visite al cimitero
Anche le origini della festa dei defunti risalgono all’antichità, più precisamente all’inizio del Decimo secolo. In quel periodo nel convento di Cluny, in Francia, viveva l’abate benedettino Odilone, canonizzato da Clemente VI nel 1345 (la sua memoria liturgica ricorre il 1° gennaio). Il monaco era talmente devoto alle anime del Purgatorio da dedicare loro messe, preghiere e penitenze. Secondo la tradizione un giorno, tornando dalla Terra Santa, uno dei suoi confratelli gli raccontò una storia che lo colpì moltissimo: dopo avere fatto naufragio, il monaco era approdato sulle coste della Sicilia dove aveva incontrato un eremita che gli aveva riferito di avere sentito provenire da una grotta i lamenti delle anime del Purgatorio e le urla dei demoni che gridavano proprio contro Odilone. Sentita questa storia, l’abate ordinò ai suoi monaci di far suonare le campane dell’abbazia con rintocchi funebri dopo la celebrazione dei vespri del 1° novembre, quelli dei Santi, per commemorare i Morti.
Il giorno dopo, dunque il 2 novembre, l’eucaristia sarebbe stata offerta per la pace di tutti i defunti. In seguito il rito fu esteso a tutta la Chiesa cattolica. Ancora oggi è consuetudine, in quello che viene comunemente chiamato il “giorno dei morti”, recarsi al cimitero e portare fiori sulle tombe dei propri cari. In molte località italiane, per celebrare la giornata, si usa anche preparare dei dolci, i cosiddetti “dolci dei morti”.
di Tiziana Lupi
Santi e Morti: tra storia e riti
|
FESTIVITA’ DI OGNISSANTI – E – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. E’ la festa cattolica di tutti i santi con la quale si sogliono onorare non solo i santi, iscritti nel Martirologio romano e nel calendario delle singole Chiese, ma tutti i trapassati che godono la gloria del Paradiso. Di origine antica, la festività di Ognissanti, dapprima dedicata ai soli martiri, era celebrata, nelle varie Chiese, subito dopo la Pasqua; fu spostata, poi dopo la Pentecoste. Il 13 maggio 609, con decorrenza 610, il Papa Bonifacio IV dedicò il Pantheon in onore della Madre di Dio e di tutti i martiri e ogni anno se ne celebrava l’anniversario con grande solennità e largo concorso di pellegrini. Da queste feste sembra derivare quella di Tutti i Santi, fissata al primo di novembre dell’anno 835 dal Papa Gregorio IV. Più tardi, nel 998, Odilo abate di Cluny aggiungeva la celebrazione, nel giorno seguente, della festa di tutte le anime a soddisfare l ‘aspirazione generale per un giorno di commemorazione dei morti. Nell’antico e colorito, ma realistico, mondo contadino esiste un proverbio legato al primo giorno del mese di novembre: “Ognissanti, manicotti e guanti“, la comparazione è chiara: comincia la stagione fredda.
1 e 2 Novembre – Ognissanti e il giorno dei morti Poesie di Vincenzo Cardarelli Santi del mio paese
Ce ne sono di chiese e di chiesuole,
Il giorno dei morti fu ufficialmente collocato alla data del 2 Novembre nel X sec. d.c. circa, praticamente fondendosi con il 1 Novembre, già festa di ognissanti dall’anno 853, per sovrapporsi alle più antiche celebrazioni di quei giorni. Tra il popolo comunque, le vecchie abitudini furono adattate alla nuova festa e al suo mutato significato, mantenendo la credenza che in quei giorni i defunti potevano tornare tra i viventi, vagando per la terra o recandosi dai parenti ancora in vita. In tutta italia si possono ancora oggi ritrovare gesti e pratiche tradizionali per la celebrazione di queste feste. Riti popolari per i defunti – Cibo tradizionale
In quasi tutte le regioni possiamo trovare pratiche e abitudini legate a questa ricorrenza. Una delle più diffuse era l’approntare un banchetto, o anche un solo un piatto con delle vivande, dedicato ai morti.
Qualche esempio caratteristico.
In Abruzzo si decoravano le zucche, e i ragazzi di paese andavano a bussare di casa in casa domandando offerte per le anime dei morti, solitamente frutta di stagione, frutta secca e dolci. Questa tradizione è ancora viva in alcune località abruzzesi. Diffusa è anche l’usanza della questua fatta da schiere di ragazzi o di contadini e artigiani che vanno di casa in casa cantando un’appropriata canzone. A Pettorano sul Gizio (Abruzzo) essa suona così:
In Calabria, nelle comunità italo-albanesi, ci si avviava praticamente in corteo verso i cimiteri: dopo benedizioni e preghiere per entrare in contatto con i defunti, si approntavano banchetti direttamente sulle tombe, invitando anche i visitatori a partecipare.
In Emilia Romagna nei tempi passati, i poveri andavano di casa in casa a chiedere “la carita’ di murt“, ricevendo cibo dalle persone da cui bussavano. In Friuli – a quanto informa l’Osterimann – “i contadini lasciano un lume acceso, un secchio d’acqua e un po’ di pane sul desco“. E’ il motivo che ispira la già ricordata poesia del Pascoli “La tovaglia“, dove la sensazione della presenza dei morti nella casa, nel silenzio della notte, è resa in maniera oltremodo commovente e suggestiva:
Stanno li sino a domani Sempre in Friuli, come del resto nelle vallate delle Alpi lombarde, si crede che i morti vadano in pellegrinaggio a certi santuari, a certe chiese lontane dall’abitato, e chi vi entrasse in quella notte le vedrebbe affollate da una moltitudine di gente che non vive più e che scomparirà al canto del gallo o al levar della “bella stella“. A queste credenze s’ispira uno dei più significativi racconti di Caterina Percoto, la ben nota scrittrice friulana, che tanti motivi trasse dal folklore della sua terra. Questa presenza dei morti, avvertita con un’intensità che raggiunge la potenza di una visione, è però sempre associata, nella mentalità popolare, all’azione benefica e alla speranza nella beatitudine eterna. In Lombardia abbiamo invece gli oss de mord, o oss de mort, fatti con pasta e mandorle toste, cotti al forno, di forma bislunga, con vago sapore di cannella in particolare: A Bormio, la notte del 2 novembre si era soliti mettere sul davanzale una zucca riempita di vino e, in alcune case, si imbandisce la cena. Ma anche nel Vigevanasco (Vigevano) e in Lomellina si suole mettere in cucina un secchio (l’acqua fresca, una zucca di vino, piena, e sotto il camino il fuoco acceso e le sedie attorno al focolare“ A Comacchio c’e’ invece il punghen cmàciàis, il Topino Comacchiese, dolce a forma di topo preparato in casa…
In Piemonte, si soleva per cena lasciare un posto in più a tavola, riservato ai defunti che sarebbero tornati in visita. In Val d’Ossola sembra esserci una particolarità in tal senso: dopo la cena, tutte le famiglie si recavano insieme al cimitero, lasciando le case vuote in modo che i morti potessero andare lì a ristorarsi in pace. Il ritorno alle case era poi annunciato dal suono delle campane, perchè i defunti potessero ritirarsi senza fastidio. In Puglia la sera precedente il due novembre, si usa ancora imbandire la tavola per la cena, con tutti gli accessori, pane acqua e vino, apposta per i morti, che si crede tornino a visitare i parenti, approfittando del banchetto e fermandosi almeno sino a natale o alla befana. Sempre in Puglia, ad Orsara in particolare, la festa veniva (e viene ancora chiamata) Fuuc acost e coinvolge tutto il paese. Si decorano le zucche chiamate Cocce priatorje, si accendono falò di rami di ginestre agli incroci e nelle piazze e si cucina sulle loro braci; anche qui comunque gli avanzi vengono riservati ai morti, lasciandoli disposti agli angoli delle strade. Diffusa è anche l’usanza della questua fatta da schiere di ragazzi o di contadini e artigiani che vanno di casa in casa cantando un’appropriata canzone. Questa costumanza in Puglia si chiama senz’altro cercare “l’aneme de muerte“ e si apre con questa specie di breve serenata rivolta alla massaia:
In Sardegna dopo la visita al cimitero e la messa, si tornava a casa a cenare, con la famiglia riunita. A fine pasto però non si sparecchiava, lasciando tutto intatto per gli eventuali defunti e spiriti che avrebbero potuto visitare la casa durante la notte. Prima della cena, i bambini andavano in giro per il paese a bussare alle porte, dicendo: <<Morti, morti…>> e ricevendo in cambio dolcetti, frutta secca e in rari casi, denaro. In Sicilia c’e’ l’usanza di preparare doni e dolci per i bambini, ai quali viene detto che sono regali portati dai parenti trapassati. I genitori infatti raccontano ai figli che se durante l’anno sono stati buoni e hanno recitato le preghiere per le anime dei defunti, i “morti“ porteranno loro dei doni. Dolci Tradizionali In Sicilia troviamo la mani, un pane ad anello modellato a forma di unico braccio che unisce due mani, e il pane dei morti, un pane di forma antropomorfa che originariamente si suppone fosse un’offerta alimentare alle anime dei parenti morti
Le strenne. In Sicilia, le anime dei morti, il 2 novembre, recano i doni ai bimbi, doni che vengono appunto chiamati “cose dei morti“. Per ottenerli, i bimbi recitano questa preghiera:
cose dei morti, cioè regali, mettetemene assai; s’intende nella scarpetta o nel cestello che i bimbi lasciano la sera appesa alla finestra o a capo del letto. A Palermo una antica tradizione, legata alla festa dei morti, voleva che i genitori regalavano ai bambini dolci e giocattoli, dicendo loro che erano stati portati in dono dalle anime dei parenti defunti. Di solito per i maschietti si usava donare armi giocattolo, alle bimbe: bambole, passeggini, assi da stiro, fornelli. I più facoltosi regalavano tricicli e biciclette fiammanti. Al mattino si trovava il regalo nascosto in un punto insolito della casa, nella notte tra l’1 e il 2 novembre. La sera prima si nascondeva la grattugia perché si pensava che i defunti, a chi si fosse comportato male, sarebbero andati a grattare i piedi! La festa ha un origine e un significato che si collegano al banchetto funebre, di cui si ha ancora un ricordo nel “consulu siciliano“ , il pranzo che i vicini di casa offrivano ai parenti, dopo che il defunto era stato tumulato. Celebri tra questi dolci sono quelli a forma umana, quali “i pupi ri zuccaru“ detta Pupaccena: una statuetta cava fatta di zucchero indurita e dipinta con colori leggeri con figure tradizionali (Paladini, ballerini ed altri personaggi del mondo infantile) o di pasta di miele o i biscotti detti “ossa ri muortu“ o “u pupu cu l’ovu”.
Tipici sono la tradizionale “muffulietta“, un tipo particolare di pane (spugnoso e morbido) con poca mollica che si “conza“ (si prepara) con OLIO, ACCIUGA, ORIGANO, SALE E PEPE con la variante del POMODORO fresco. I frutti di martorana, fatti con pasta di mandorle e poi dipinti, sono spesso vere opere d’arte per la straordinaria somiglianza a quelli veri: nespole, castagne, pesche, fichidindia, arance e tanti altri che riempiono, associati al “misto“ (u ruci mmiscu): il dolce misto fatto da rimasugli di biscotti impastati una seconda volta, bianco per la velatura di zucchero e marrone per la presenza di cacao; U CANNISTRU, con frutta secca, fichi secchi e datteri e che riempie la base , la martorana e i biscotti, ‘a MURTIDDA e il tutto sormontato dalla Pupaccena. Per renderlo più scintillante bastava aggiungere dei cioccolattini con carta stagnola e filamenti di carta di diversi colori. a Palermo si svolge La Fiera dei Morti: bancarelle offrono ai vari visitatori nonché ai genitori l’opportunità di potere acquistare giocattoli, vestiario, dolciumi di ogni genere per preparare il tradizionale “Cannistru“. “In Cianciana (Sicilia) escono dal Convento di S. Antonio de’ Riformati; attraversano la piazza e arrivano al Calvario: quivi, fatta una loro preghiera al Crocefisso, scendono per la via del Carmelo. E’ nel passaggio appunto che lasciano i loro regali ai fanciulli buoni. In Casteltermini (Sicilia) il viaggio è ogni sette anni, e i morti lo fanno attorno al paese, lungo le vie che devono percorrere le processioni solenni“
LE FAVE Cibo di rito per la ricorrenza dei morti sono le fave. “Secondo gli antichi – dice il Pitrè – le fave contenevano le anime dei loro trapassati: erano sacre ai morti. Presso i Romani avevano il primo posto nei conviti funebri“.
Anche quest’uso fu dalla pietà cristiana portato sopra un piano più alto e riempito di un nuovo significato: poiché le fave, o anche i ceci lessi, in capaci bigonci venivano posti agli angoli delle strade e ciascuno vi poteva attingere a volontà. S’intende che più vi attingevano i poveri. Ancora oggi in Capitanata (Puglia) “molte famiglie cuociono in grosse caldaie notevoli quantità di ceci o di grano, che condiscono col succo degli acini di melograno, e ne offrono dei piatti ai poveri in suffragio delle anime dei defunti“. Ora le fave dei morti sono, di regola, sostituite con dolci di egual nome, e di foggia più o meno simile.
In Veneto le zucche venivano svuotate, dipinte e trasformate in lanterne, chiamate lumere: la candela all’interno rappresentava cristianamente l’idea della resurrezione.
Per i contenuti di questa pagina ringraziamo i siti ed i libri: (Estratto da: Paolo Toschi, “Invito al folklore italiano“, Studium, Roma) www.correrenelverde.it da cui abbiamo preso molte notizie. Vedi anche: http://www.grifasi-sicilia.com/festedeimorti.html
|
Alda Merini : Ognissanti
Festa di Ognissanti:
la scomparsa di una grande donna
LA SEMPLICITA’-VENTO
La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri.
E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri.
Abbiamo timore di essere fraintesi, di apparire fragili,
di finire alla mercé di chi ci sta di fronte.
Non ci esponiamo mai.
Perché ci manca la forza di essere uomini,
quella che ci fa accettare i nostri limiti,
che ce li fa comprendere, dandogli senso e trasformandoli in energia, in forza appunto.
Io amo la semplicità che si accompagna con l’umiltà.
Mi piacciono i barboni.
Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle,
sentire gli odori delle cose,
catturarne l’anima.
Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo.
Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore.
Alda Merini
In un pomeriggio che prelude alla primavera (è il 4 marzo 2008), nella sua casa milanese sui Navigli, la poetessa Alda Merini, scomparsa l’anno scorso nella solennità di Tutti i Santi, rivela al suo intervistatore Antonio Prudenzano: «Ieri ho scritto una poesia sulla Sindone, pur non avendola mai vista dal vivo. Ho usato la fantasia. Mi sono lasciata trasportare dalle sensazioni. La poesia è una g…razia ricevuta, un dono di Dio… Pensi a San Francesco, di cui di recente ho scritto [Una voce per Francesco, Frassinelli, Milano 2007, cfr. FVS, febbraio 2008, NdA]. Era un uomo gioioso, in pace con la vita e con Dio. Ed era un grandissimo poeta.» È stata, quella sulla Sindone, una delle sue ultime poesie, conferma Giuliano Grittini, amico e fotografo personale della poetessa, che le fu vicino negli ultimi attimi di vita: «Soffriva, – confida al giornalista Fabrizio Tassi – ma era sempre pronta a scherzare anche col medico che la seguiva. Le ho fatto anche delle foto in ospedale. Mi ha dettato delle poesie. Una delle ultime era sulla Sindone: me l’ha dettata una notte in cui non riusciva a dormire.» Il tema della Croce, l’enigma di Gesù, il suo volto sfigurato, l’orrore di quelle piaghe sparse sul corpo, dei dolorosi segni impressi nelle sue carni dal legno del patibolo, sono ora raccolti in florilegio nella raccolta postuma pubblicata lo scorso dicembre da Einaudi, quale testamento poetico della Merini, a cura di Ambrogio Borsani, di cui la poetessa era ancora riuscita a correggere le bozze benché già malata, e che teneva molto a vedere stampata, ma purtroppo non ha più fatto in tempo. Il titolo è Il carnevale della croce: titolo stupefacente e visionario, di grande potenza e violenza espressiva, che riprende il commento di Luca Bragaja (in Nel cerchio di pensiero, 2003), il quale, dando un giudizio complessivo sull’intera opera poetica della Merini, la definisce «”carnevale della crocifissione”, culmine della corporeità violata e simbolo denso del misticismo cristiano.» Un commento che la Merini stessa, probabilmente, aveva ispirato, rimuginando con evidente assiduità la pregnanza di quell’espressione nel suo immenso valore universale e nella dirompente potenza immaginifica, tanto da renderne conto successivamente nel 2007 con perfetta lucidità ed estremo e totale disincanto, per il Calvario in primis (nei suoi versi insieme «diamante» e «teatro magnifico della derisione») e per tutti i Golgota della terra: «Il Golgota è il luogo del Cranio, il centro del mondo. Ma è anche il carnevale della Croce. Perché, mentre portavano a morire atrocemente i poveri condannati, i carnefici si divertivano. Ecco quello che non distingue l’uomo dalla bestia: la tortura, l’essere carnefice dell’altro. E gli uomini sanno farlo con sapienza. Cristo viene issato, viene preso in giro. Però tutto questo l’aveva già previsto. Anche la Madonna. Ma l’amore accetta tutto.» (Così in un’intervista a Roberto Beretta). Sì, è vero: l’amore accetta tutto, come lo ha accettato la poetessa dei Navigli nella sua travagliata e turbolenta esistenza, in particolar modo nella ultradecennale permanenza in manicomio, dove era approdata con lo strazio del distacco appena dopo la nascita dell’amata Barbara, l’ultima delle sue figlie: «Ho conosciuto Gerico, / ho avuto anch’io la mia Palestina, / le mura del manicomio / erano le mura di Gerico / e una pozza di acqua infettata / ci ha battezzati tutti. / Lì dentro eravamo ebrei / e i Farisei erano in alto / e c’era anche il Messia / confuso dentro la folla: / un pazzo che urlava al Cielo / tutto il suo amore in Dio…» (da La Terra Santa, raccolta del 1984 considerata il suo capolavoro, la sua consacrazione poetica, scritta in appena otto giorni mentre il marito stava morendo di cancro). Proprio negli abissi di quell’inferno, infatti, Alda Merini si riavvicina a Dio (da ragazza, lei dice, avrebbe voluto farsi suora, ma suo padre non volle), i suoi occhi brancolanti nelle tenebre rivedono la luce, conosce la risurrezione attraverso la sua sofferenza e quella di chi la circonda. Ma il dolore (è ancora lei a dirlo), purtroppo non si stempera col tempo: lavora nel profondo e corrode; non si fa più lieve e non abitua, ma rende più sensibili e riluttanti al patire: al proprio patire e all’altrui. Ed ecco come la sua pena si scioglie in pagine amate e commoventi, fino alla delicata e confidenziale trasparenza di versi d’amore e senza vergogna come questi: «Gesù, / forse è per paura delle tue immonde spine / ch’io non ti credo, / per quel dorso chino sotto la croce / ch’io non voglio imitarti. / Forse, come fece San Pietro, / io ti rinnego per paura del pianto. / Però io ti percorro ad ogni ora / e sono lì in un angolo di strada / e aspetto che tu passi. / E ho un fazzoletto, amore, / che nessuno ha mai toccato, / per tergerti la faccia.» Siamo nel 2001 quando Alda Merini pubblica questa poesia in Corpo d’amore. Un incontro con Gesù (ora in Il carnevale della croce, p. 32), che sgorga dall’intimo come flusso di coscienza ed è capace di scavare nelle profondità dell’io e di risalirvi in un’esplosione di stupore: «In ogni parte, / malgrado tu fossi interamente ignudo…, / io ti ho visto salire le colline della mia origine / e non so / da vera innamorata qual sono / come tu faccia a conoscermi / e chi ti abbia messo dentro di me. » È lo stupore dell’innamorata del Cantico dei cantici, che scopre di essere amata da quella “Presenza onnipresente” che la insegue e la trova «in ogni parte», in ogni luogo, nei recessi del suo cuore e nelle tenebre della sua mente; è lo stupore mistico di fronte alla presenza di un Dio «ignudo», umile, disarmato, che «ha espresso il suo amore per l’uomo col pianto » e la conosce ancor prima di farsi conoscere, è l’atteggiamento nuovo sul quale si fonda e si consolida il suo amore per il Cristo incarnato, sofferente e crocifisso, quel Cristo che in un primo tempo si fa fatica umanamente ad accettare, così esposto alla sua debolezza, ed è più facile rinnegare come Pietro, nonostante la fede e i suoi migliori propositi, per paura di doverlo imitare. Ma poi, ad un certo punto, si arriva a riconoscerne la forza: la forza del dono di sé, dell’amore totale. Per questo, se l’amore è il sentimento che sempre prevale in Alda Merini, e diciamolo: in tutte le sue declinazioni, in forma di eros come di agape («al di là di ogni immondizia / e sutura, c’è la grande speranza / che il tempo redima i folli / e l’amore spazzi via ogni cosa», così in una delle sue ultime poesie d’amore contenute nel Carnevale della croce), negli ultimi tempi, di conversione in conversione, esso assume la forma più alta, raggiunge il livello dei mistici, manifestandosi nella contemplazione del mistero della passione e della morte di Gesù Cristo, «uomo dei dolori che ben conosce il patire», non più con il raccapriccio iniziale, ma con tutta la tenerezza dell’innamorata, con tutta l’acuta sensibilità e la pietas della donna, che – novella Veronica – sulla via del Calvario gli deterge il viso dal sangue e dal sudore. E, ai piedi della croce, si getta ad abbracciarlo con lo strazio della madre: di quella Madre, «che si legò ai piedi del figlio / per essere trascinata con lui sulla croce / e ne venne sciolta / perché continuasse a vivere nel suo dolore» (da Poema della croce, ora nel volumetto einaudiano a p. 55). Tale è ormai, sul finire della vita, il radicamento della Merini in Gesù, che mentre nei suoi versi fa risuonare la voce di lui nell’esclamazione: «Io non sono morto, non morirò mai», gli fa eco con la sua voce in questo inno di risurrezione: «Se mi inchiodano sopra una croce, non fanno che inchiodare le ali di una farfalla finalmente libera.» Funerali di stato (il 4 novembre 2009) nel Duomo di Milano per Alda Merini, dove lei tante volte era andata a dire e cantare i suoi versi con Giovanni Nuti. Al termine della santa messa presieduta da mons. Brambilla, vicario episcopale, lo stesso Nuti, il cantautore toscano legato dal 1994 da un sodalizio umano e artistico molto forte con la poetessa in odore di Nobel, ha voluto offrile col canto una sua poesia, forse la prediletta: Il legno. Sì, quel legno della croce che, Cristo esclama per voce di Alda, «come una falce / falcerà tutti i reprobi della terra. / Il legno come cosa giusta. / Io, figlio di un falegname, / ho scelto il legno per morire, / ma dal legno si alzerà la mia gloria.» Rosa Dimichino in “Francesco il Volto Secolare”, febbraio 2010. In un pomeriggio che prelude alla primavera (è il 4 marzo 2008), nella sua casa milanese sui Navigli, la poetessa Alda Merini, scomparsa l’anno scorso nella solennità di Tutti i Santi, rivela al suo intervistatore Antonio Prudenzano: «Ieri ho scritto una poesia sulla Sindone, pur non avendola mai vista dal vivo. Ho usato la fantasia. Mi sono lasciata trasportare dalle sensazioni. La poesia è una g…razia ricevuta, un dono di Dio… Pensi a San Francesco, di cui di recente ho scritto [Una voce per Francesco, Frassinelli, Milano 2007, cfr. FVS, febbraio 2008, NdA]. Era un uomo gioioso, in pace con la vita e con Dio. Ed era un grandissimo poeta.»
È stata, quella sulla Sindone, una delle sue ultime poesie, conferma Giuliano Grittini, amico e fotografo personale della poetessa, che le fu vicino negli ultimi attimi di vita: «Soffriva, – confida al giornalista Fabrizio Tassi – ma era sempre pronta a scherzare anche col medico che la seguiva. Le ho fatto anche delle foto in ospedale. Mi ha dettato delle poesie. Una delle ultime era sulla Sindone: me l’ha dettata una notte in cui non riusciva a dormire.»
Il tema della Croce, l’enigma di Gesù, il suo volto sfigurato, l’orrore di quelle piaghe sparse sul corpo, dei dolorosi segni impressi nelle sue carni dal legno del patibolo, sono ora raccolti in florilegio nella raccolta postuma pubblicata lo scorso dicembre da Einaudi, quale testamento poetico della Merini, a cura di Ambrogio Borsani, di cui la poetessa era ancora riuscita a correggere le bozze benché già malata, e che teneva molto a vedere stampata, ma purtroppo non ha più fatto in tempo.
Il titolo è Il carnevale della croce: titolo stupefacente e visionario, di grande potenza e violenza espressiva, che riprende il commento di Luca Bragaja (in Nel cerchio di pensiero, 2003), il quale, dando un giudizio complessivo sull’intera opera poetica della Merini, la definisce «”carnevale della crocifissione”, culmine della corporeità violata e simbolo denso del misticismo cristiano.»
Un commento che la Merini stessa, probabilmente, aveva ispirato, rimuginando con evidente assiduità la pregnanza di quell’espressione nel suo immenso valore universale e nella dirompente potenza immaginifica, tanto da renderne conto successivamente nel 2007 con perfetta lucidità ed estremo e totale disincanto, per il Calvario in primis (nei suoi versi insieme «diamante» e «teatro magnifico della derisione») e per tutti i Golgota della terra: «Il Golgota è il luogo del Cranio, il centro del mondo. Ma è anche il carnevale della Croce. Perché, mentre portavano a morire atrocemente i poveri condannati, i carnefici si divertivano. Ecco quello che non distingue l’uomo dalla bestia: la tortura, l’essere carnefice dell’altro. E gli uomini sanno farlo con sapienza. Cristo viene issato, viene preso in giro. Però tutto questo l’aveva già previsto. Anche la Madonna. Ma l’amore accetta tutto.» (Così in un’intervista a Roberto Beretta).
Sì, è vero: l’amore accetta tutto, come lo ha accettato la poetessa dei Navigli nella sua travagliata e turbolenta esistenza, in particolar modo nella ultradecennale permanenza in manicomio, dove era approdata con lo strazio del distacco appena dopo la nascita dell’amata Barbara, l’ultima delle sue figlie: «Ho conosciuto Gerico, / ho avuto anch’io la mia Palestina, / le mura del manicomio / erano le mura di Gerico / e una pozza di acqua infettata / ci ha battezzati tutti. / Lì dentro eravamo ebrei / e i Farisei erano in alto / e c’era anche il Messia / confuso dentro la folla: / un pazzo che urlava al Cielo / tutto il suo amore in Dio…» (da La Terra Santa, raccolta del 1984 considerata il suo capolavoro, la sua consacrazione poetica, scritta in appena otto giorni mentre il marito stava morendo di cancro).
Proprio negli abissi di quell’inferno, infatti, Alda Merini si riavvicina a Dio (da ragazza, lei dice, avrebbe voluto farsi suora, ma suo padre non volle), i suoi occhi brancolanti nelle tenebre rivedono la luce, conosce la risurrezione attraverso la sua sofferenza e quella di chi la circonda. Ma il dolore (è ancora lei a dirlo), purtroppo non si stempera col tempo: lavora nel profondo e corrode; non si fa più lieve e non abitua, ma rende più sensibili e riluttanti al patire: al proprio patire e all’altrui.
Ed ecco come la sua pena si scioglie in pagine amate e commoventi, fino alla delicata e confidenziale trasparenza di versi d’amore e senza vergogna come questi: «Gesù, / forse è per paura delle tue immonde spine / ch’io non ti credo, / per quel dorso chino sotto la croce / ch’io non voglio imitarti. / Forse, come fece San Pietro, / io ti rinnego per paura del pianto. / Però io ti percorro ad ogni ora / e sono lì in un angolo di strada / e aspetto che tu passi. / E ho un fazzoletto, amore, / che nessuno ha mai toccato, / per tergerti la faccia.»
Siamo nel 2001 quando Alda Merini pubblica questa poesia in Corpo d’amore. Un incontro con Gesù (ora in Il carnevale della croce, p. 32), che sgorga dall’intimo come flusso di coscienza ed è capace di scavare nelle profondità dell’io e di risalirvi in un’esplosione di stupore: «In ogni parte, / malgrado tu fossi interamente ignudo…, / io ti ho visto salire le colline della mia origine / e non so / da vera innamorata qual sono / come tu faccia a conoscermi / e chi ti abbia messo dentro di me. »
È lo stupore dell’innamorata del Cantico dei cantici, che scopre di essere amata da quella “Presenza onnipresente” che la insegue e la trova «in ogni parte», in ogni luogo, nei recessi del suo cuore e nelle tenebre della sua mente; è lo stupore mistico di fronte alla presenza di un Dio «ignudo», umile, disarmato, che «ha espresso il suo amore per l’uomo col pianto » e la conosce ancor prima di farsi conoscere, è l’atteggiamento nuovo sul quale si fonda e si consolida il suo amore per il Cristo incarnato, sofferente e crocifisso, quel Cristo che in un primo tempo si fa fatica umanamente ad accettare, così esposto alla sua debolezza, ed è più facile rinnegare come Pietro, nonostante la fede e i suoi migliori propositi, per paura di doverlo imitare. Ma poi, ad un certo punto, si arriva a riconoscerne la forza: la forza del dono di sé, dell’amore totale.
Per questo, se l’amore è il sentimento che sempre prevale in Alda Merini, e diciamolo: in tutte le sue declinazioni, in forma di eros come di agape («al di là di ogni immondizia / e sutura, c’è la grande speranza / che il tempo redima i folli / e l’amore spazzi via ogni cosa», così in una delle sue ultime poesie d’amore contenute nel Carnevale della croce), negli ultimi tempi, di conversione in conversione, esso assume la forma più alta, raggiunge il livello dei mistici, manifestandosi nella contemplazione del mistero della passione e della morte di Gesù Cristo, «uomo dei dolori che ben conosce il patire», non più con il raccapriccio iniziale, ma con tutta la tenerezza dell’innamorata, con tutta l’acuta sensibilità e la pietas della donna, che – novella Veronica – sulla via del Calvario gli deterge il viso dal sangue e dal sudore. E, ai piedi della croce, si getta ad abbracciarlo con lo strazio della madre: di quella Madre, «che si legò ai piedi del figlio / per essere trascinata con lui sulla croce / e ne venne sciolta / perché continuasse a vivere nel suo dolore» (da Poema della croce, ora nel volumetto einaudiano a p. 55).
Tale è ormai, sul finire della vita, il radicamento della Merini in Gesù, che mentre nei suoi versi fa risuonare la voce di lui nell’esclamazione: «Io non sono morto, non morirò mai», gli fa eco con la sua voce in questo inno di risurrezione: «Se mi inchiodano sopra una croce, non fanno che inchiodare le ali di una farfalla finalmente libera.»
Funerali di stato (il 4 novembre 2009) nel Duomo di Milano per Alda Merini, dove lei tante volte era andata a dire e cantare i suoi versi con Giovanni Nuti. Al termine della santa messa presieduta da mons. Brambilla, vicario episcopale, lo stesso Nuti, il cantautore toscano legato dal 1994 da un sodalizio umano e artistico molto forte con la poetessa in odore di Nobel, ha voluto offrile col canto una sua poesia, forse la prediletta: Il legno. Sì, quel legno della croce che, Cristo esclama per voce di Alda, «come una falce / falcerà tutti i reprobi della terra. / Il legno come cosa giusta. / Io, figlio di un falegname, / ho scelto il legno per morire, / ma dal legno si alzerà la mia gloria.»
Rosa Dimichino in “Francesco il Volto Secolare”, febbraio 2010.
Solennità di TUTTI I SANTI
1 NOVEMBRE: Solennità di TUTTI I SANTI
(P. Santo Sessa dal Santuario della Madonna del Carmine)
Dal VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 5,1-12)
nel Vangelo di oggi Gesù ci parla della vera Beatitudine-Felicità:
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte:
si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
GESÙ VEDENDO MOLTA FOLLA SI MISE A INSEGNARE:
Gesù vede molta folla di poveri, affamati, bisognosi, ecc…
e si mette a insegnare, a dare Speranza a questi cuori afflitti.
BEATI VOI…:
quello di Gesù è un discorso sconvolgente e ‘rivoluzionario’:
come può essere ‘beato’ chi soffre, chi è povero…!?
Ma per Gesù non è beata la povertà o la sofferenza in se stessa,
ma è beato chi vive tutto ciò confidando in Dio che può tutto,
la sua beatitudine-felicità sarà nella ricompensa che Dio gli darà!
“Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno dei Cieli!”
A loro Gesù promette: “Il Regno è vostro!”
Non è una promessa fatta per il futuro. Il verbo è presente.
Il Regno appartiene già a loro. Loro sono beati fin da ora.
BEATI I POVERI IN SPIRITO…:
Non riguarda solo una povertà ‘materiale’ ma soprattutto ‘spirituale’,
la povertà di spirito è prima di tutto un atteggiamento interiore.
Povero in spirito è l’ANAWIM:
chi si affida e dipende totalmente da Dio
chi confida solamente in Lui, con fiducia totale.
L’Anawim, la povera per eccellenza è Maria:
“Ha guardato all’UMILTA’ (povertà-piccolezza) della sua serva…
ma GRANDI COSE ha fatto in me l’Onnipotente!”
● La seconda beatitudine parla di “afflitti” o “piangenti”,
di quanti attendono che Dio venga ad asciugare le loro lacrime:
solo Dio conosce il loro cuore, ascolta il loro grida e viene in soccorso.
● La terza beatitudine dice “Beati i miti”,
cioè coloro che si impegnano perché il mondo viva in modo fraterno.
Quante anime si spendono e hanno dato la vita per la Pace
per un mondo lacerato in cui possa esserci concordia e armonia!
● La quarta beatitudine ci dice che: “gli affamati e gli assetati della giustizia” saranno beati perché collaborano nella realizzazione del progetto di Dio….verranno sfamati e dissetati abbondantemente!
● “Beati i misericordiosi” è la quinta beatitudine.
Misericordiosi è un vocabolo che in ebraico non esiste al plurale
in quanto la misericordia è una virtù che appartiene solo al Signore
e in un sol caso è applicata al giusto (il Messia).
Possiamo essere misericordiosi verso tutti
solo se facciamo esperienza della Misericordia!
● La sesta beatitudine parla di ” Puri di cuore”,
di quanti sono semplici, integri, sinceri, autentici…
essi saranno beati perché sono i soli in grado di vedere Dio.
● La settima beatitudine dice che “quelli che fanno pace…”.
I pacifici non i ‘pacifisti’,
i portatori non di una pace ‘idealizzata’
ma i portatori di Gesù, vera e unica Pace!
● “I perseguitati” dell’ottava beatitudine
sono coloro che affidano a Dio la difesa della loro innocenza
che affidano la loro vita a Dio, come loro unico ‘rifugio’ sicuro.
LA VOSTRA RICOMPENSA È GRANDE NEI CIELI…:
non è facile vivere le Beatitudini
ma se la mèta è UNA GRANDE RICOMPENSA
se la mèta è il PREMIO che Dio ci darà PER SEMPRE
allora siamo incoraggiati a perseverare fiduciosi.
COSA DICE ALLA NOSTRA VITA CONCRETAMENTE…:
è difficile entrare in questa ‘logica’ e in questo linguaggio di Gesù,
ma sappiamo dai Santi e da persone che concretamente vivono
sulla loro pelle l’esperienza della povertà, sofferenza e ingiustizia,
offrendole e vivendole totalmente per il Signore, come siano
nella pace interiore e come vivano di una Gioia e Speranza
che solo la Fede sa donare…
Vivere le Beatitudini significa FIDARSI di Dio
nonostante la concretezza delle sofferenze che viviamo,
significa sentire di essere ‘più vicini’ a Cristo
che non ha scelto per sé la ricchezza e il successo,
ma la povertà, l’incomprensione e l’ingiustizia, fino a morire,
eppure risorgendo ha vinto ogni male dell’uomo e del mondo
e ci rende partecipi della Sua Vittoria se crediamo in Lui.
Non è facile ma se proviamo ci accorgiamo, già ora,
che ciò che Gesù promette nel Vangelo, si realizza oggi,
la fede non è illusione, è fiducia, è certezza…GIA’ ORA!!
PENSIERO SPIRITUALE: S. BERNARDO di Chiaravalle
«Che cosa ha trovato Gesù nella povertà
per amarla tanto e preferirla alle ricchezze?
O sbaglia Gesù Cristo o si sbaglia il mondo.»